Mio padre aveva poco da vivere e mi sussurrò che potevo fare quello di cui avevamo discusso poche settimane prima.
Era l’ottobre 2009 e quel momento spazzò via tutto, ogni dibattito, ogni legge, ogni caso Englaro, ogni caso Welby, ogni predica porporale, ogni monologo di Saviano, ogni suicidio di Monicelli, ogni esortazione di principio sul come dobbiamo morire. C’era un padre e c’era un figlio, non avremmo commesso l’errore fatto con mia madre.
Telefonai a un’amica, terzo elemento di quella triade affettiva padre-figlio-medico che da lustri teneva la politica fuori dalla porta, politica ben lieta, in realtà, di non entrare negli stracazzi nostri, e di lasciare che la morte di centinaia di migliaia di persone restasse accompagnata da interventi sanitari non dichiarati. Purché avvenisse nell’ombra, avvolta da quella cappa narcotica che ha sempre circondato, da noi, le cose che si fanno ma che non si dicono.
Tanto eravamo già via, da mesi, lontano dai politici, dai giudici, dai preti, lontani perché chiunque voi – altri – di fronte alla vita, nostra e dei nostri cari, smettete di esistere, non siete niente, che ci frega di come chiamate le cose, se eutanasia, accanimento, fine-vita, assassinio, o, peggio, se fate una legge incostituzionale e fatta per restare perfettamente inapplicata. Fate pure. Tanto la vita resta nostra. Altrimenti, piuttosto, la galera.
da il post
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


















































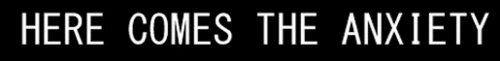













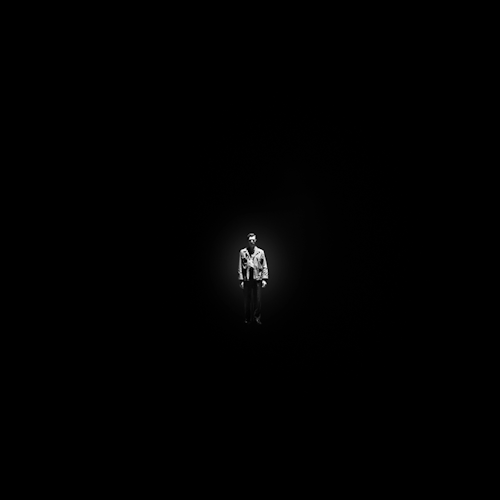

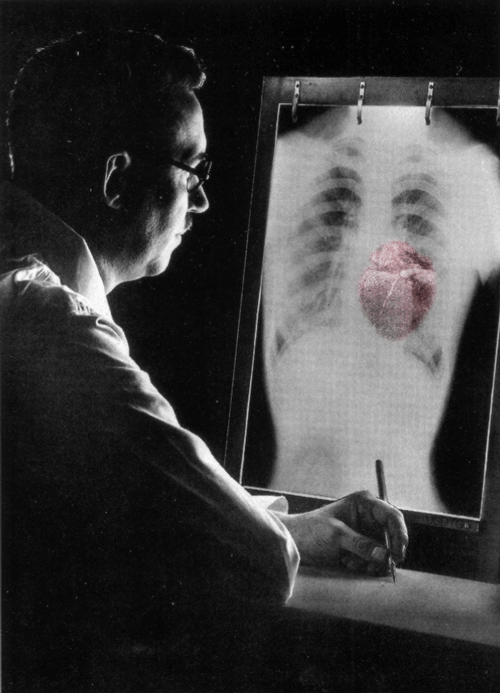

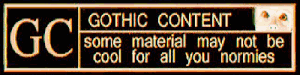
















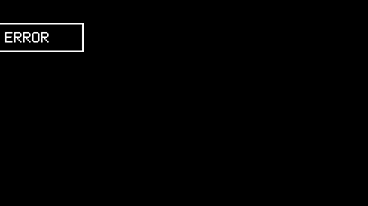

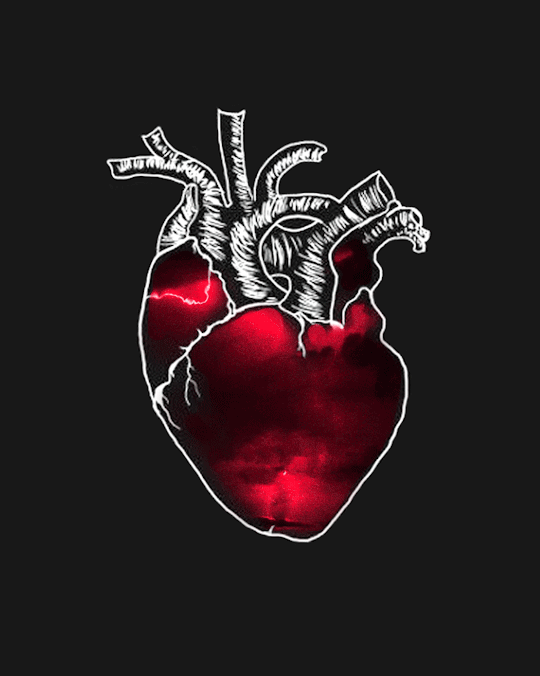










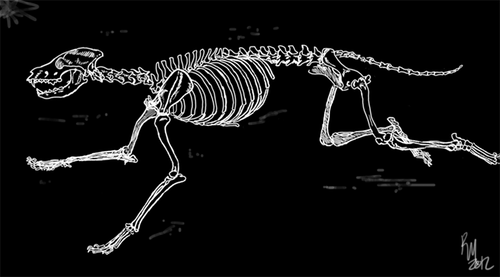







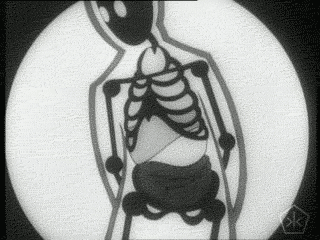







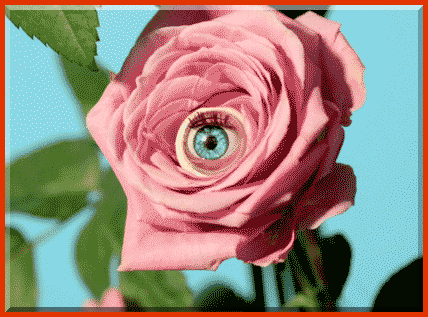
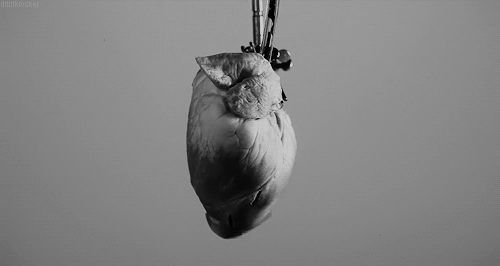
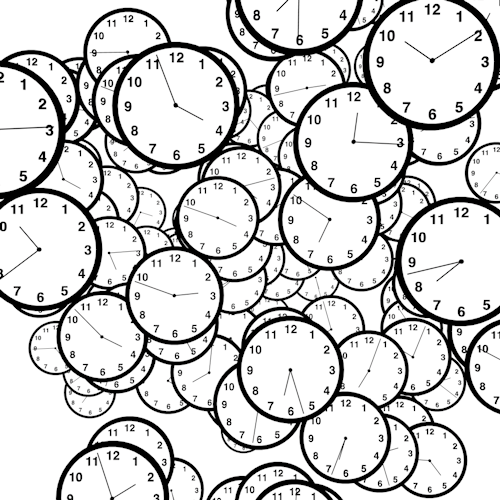



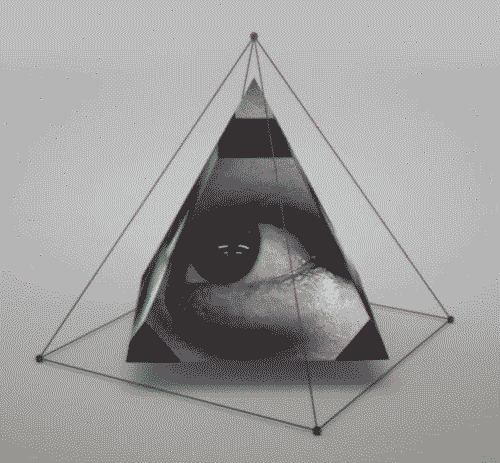


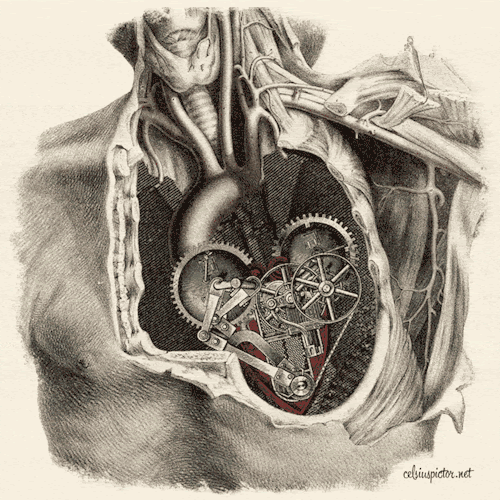
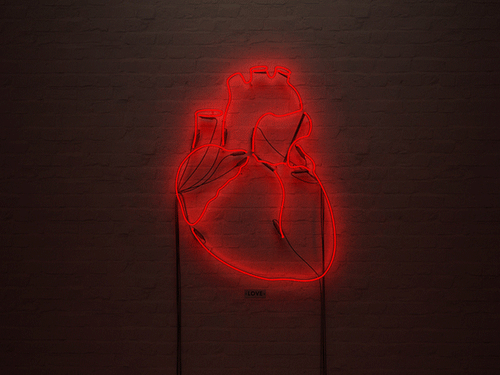











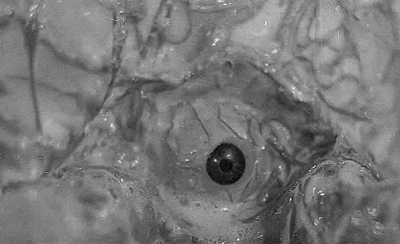
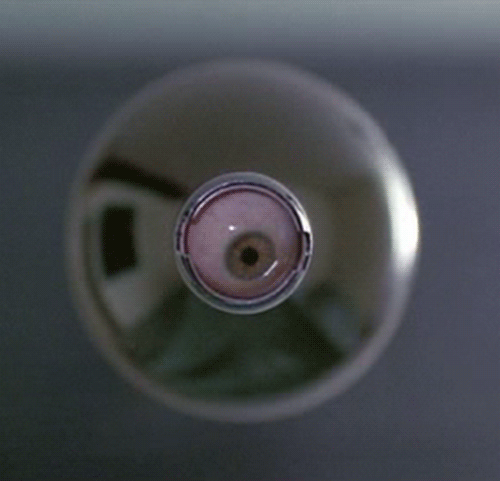



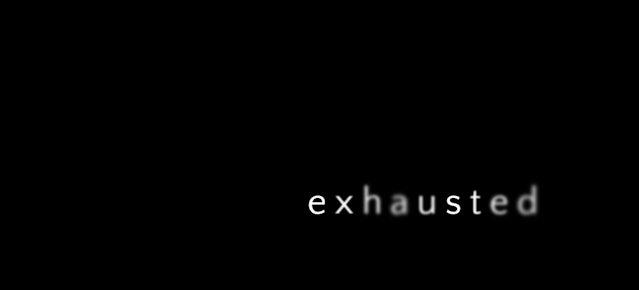

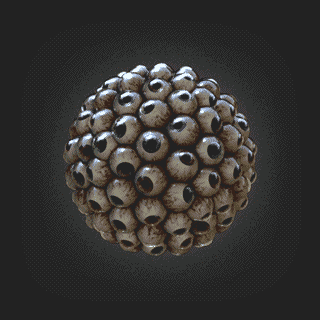

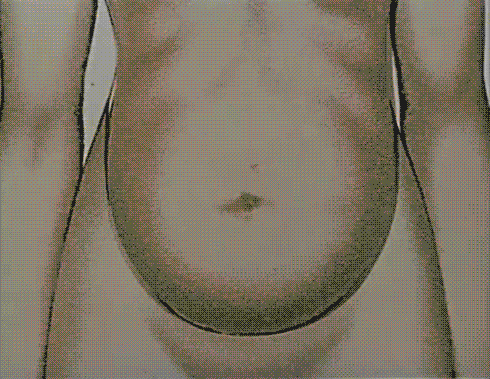



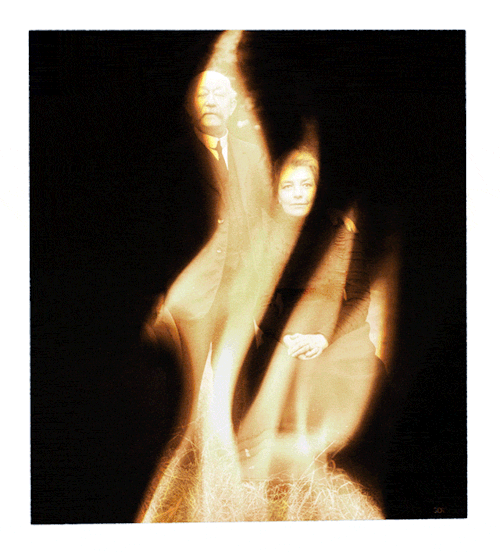

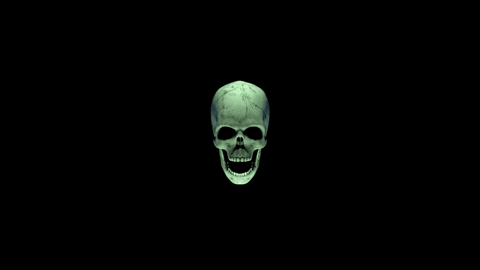

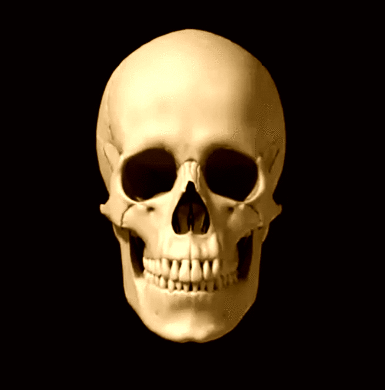

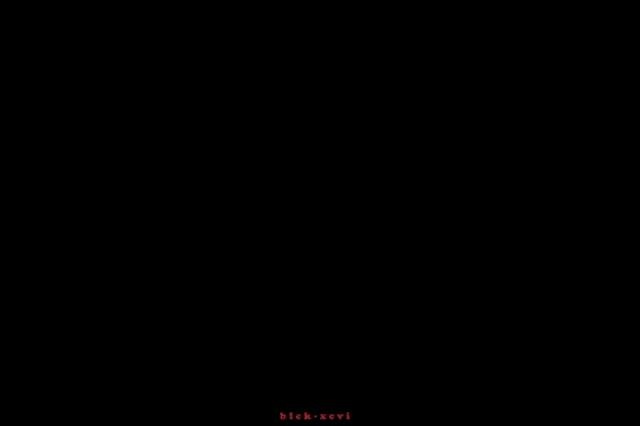


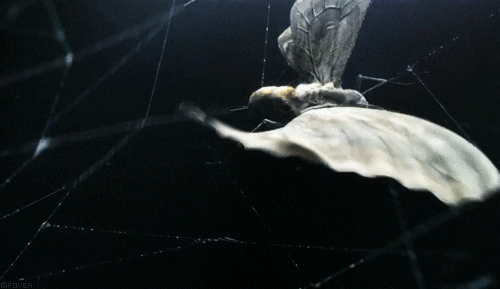



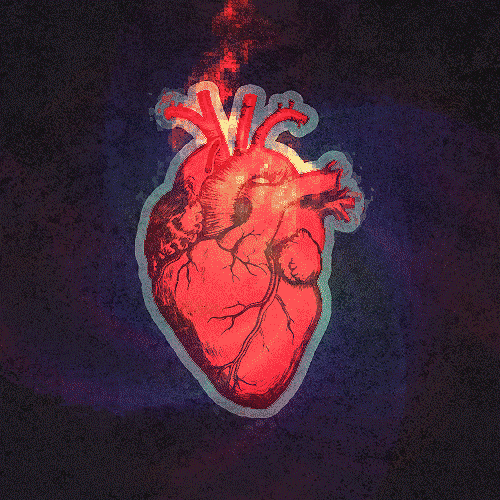
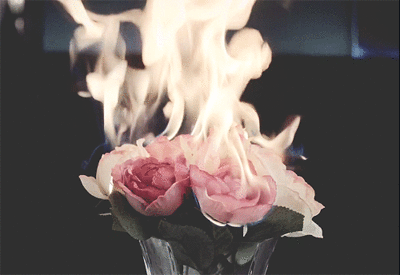

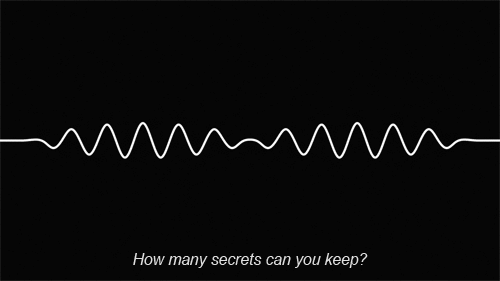


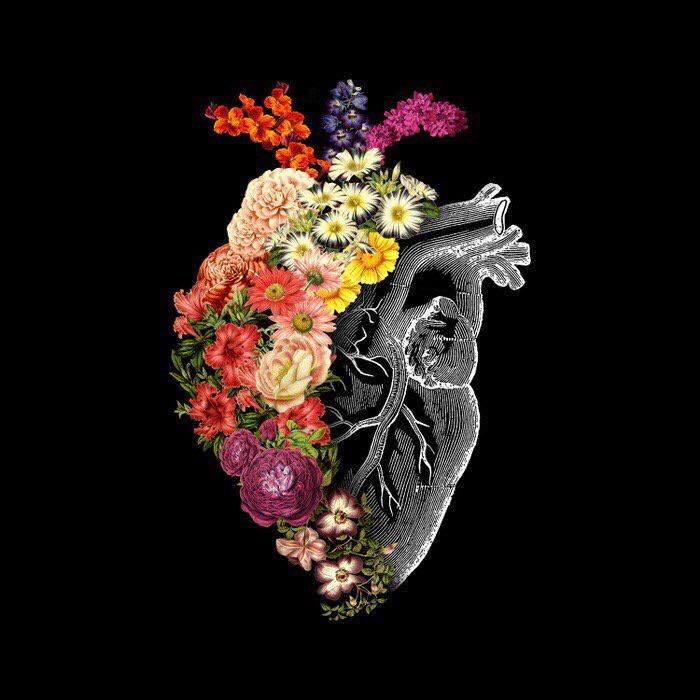
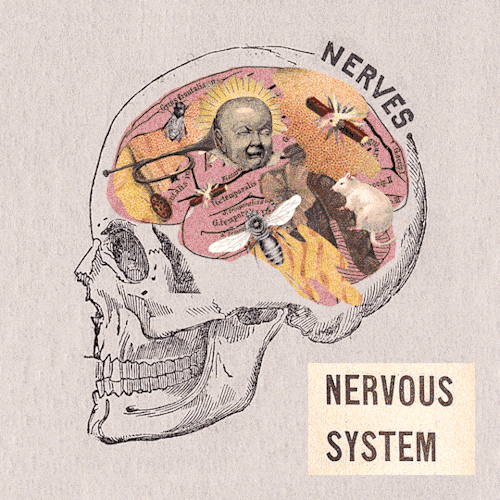



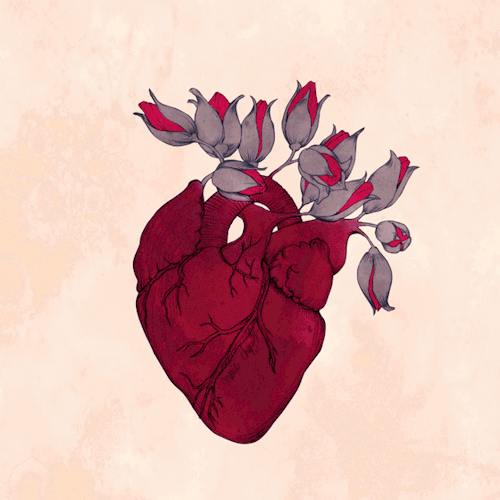
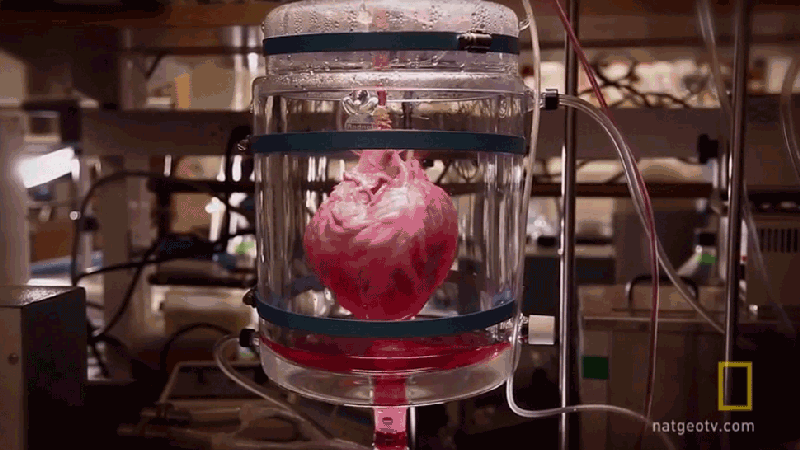

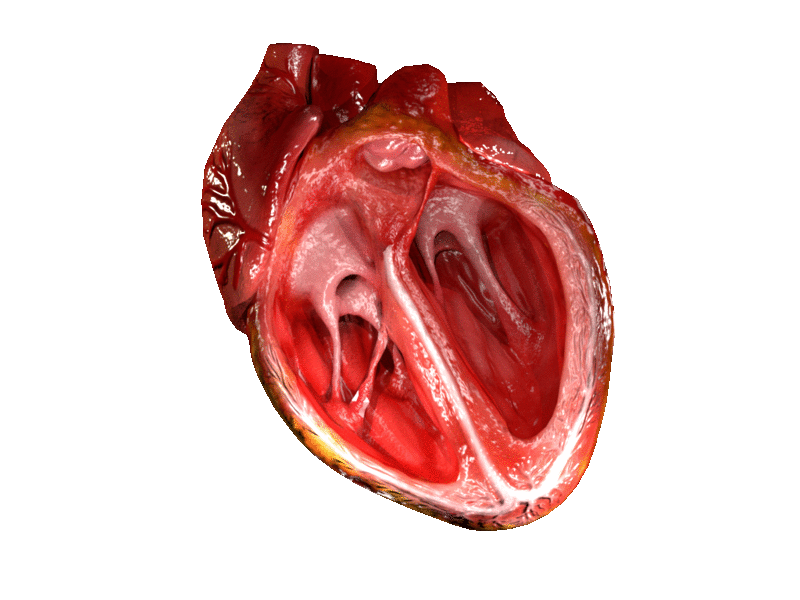
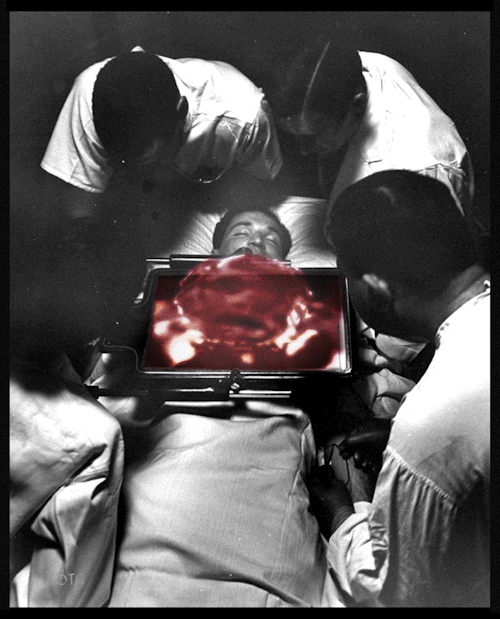
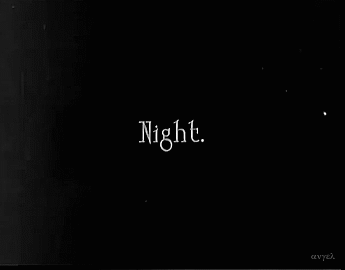

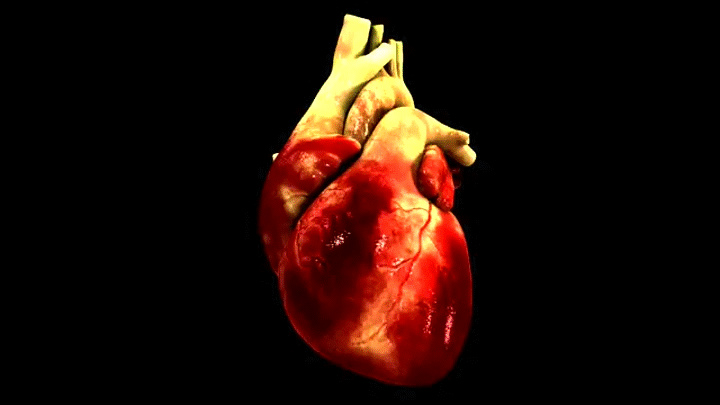
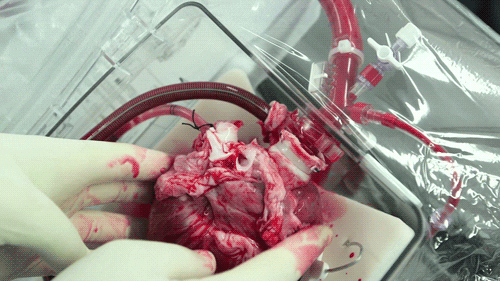
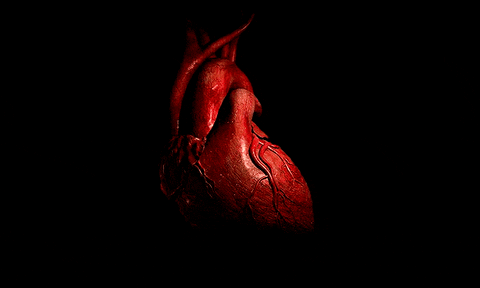


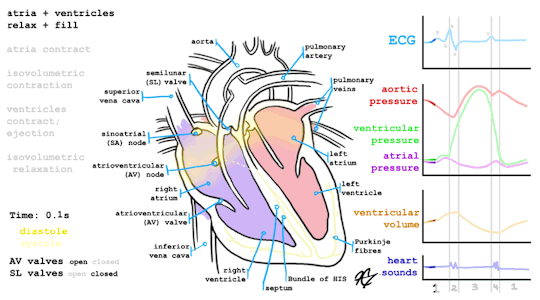

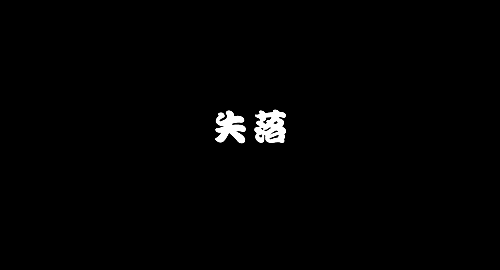


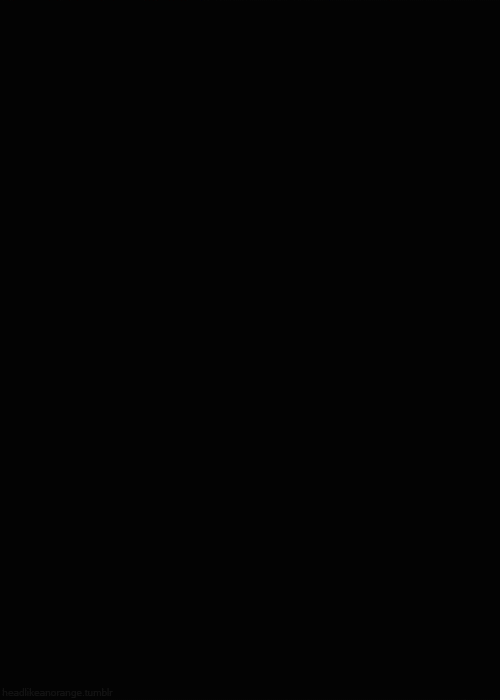





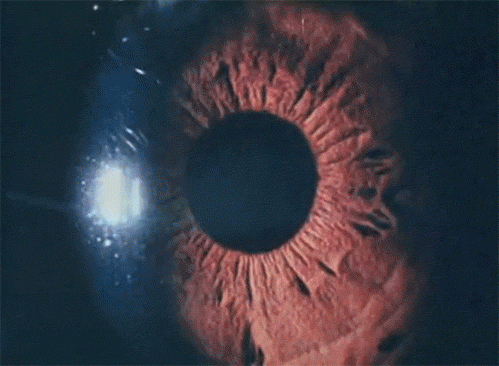










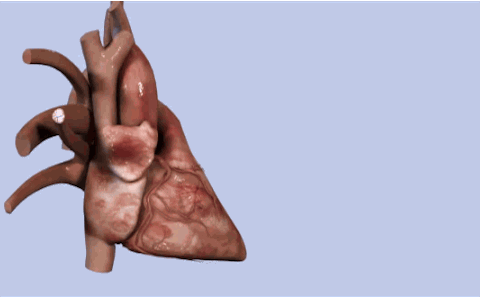







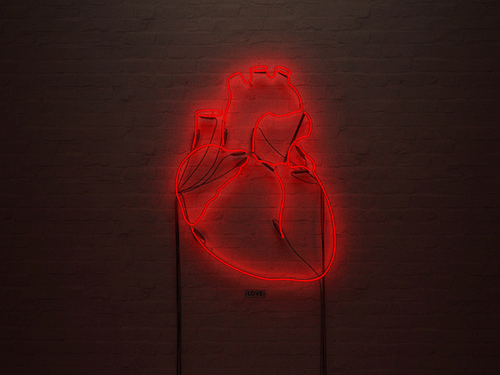


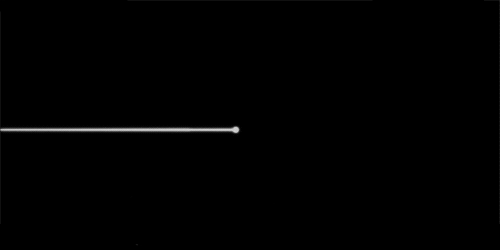






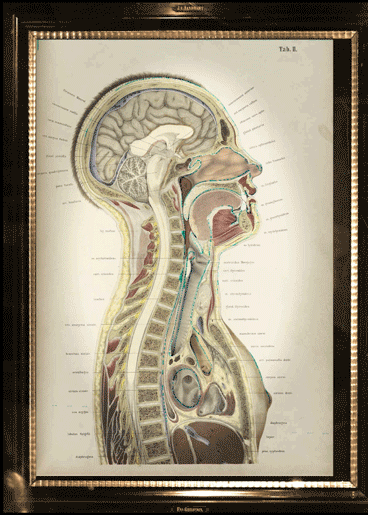







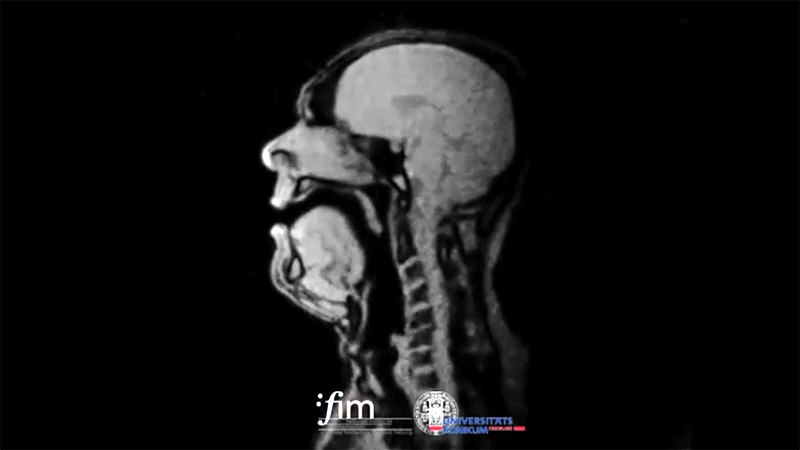
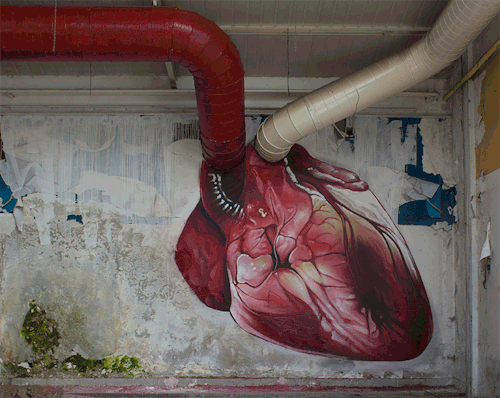










.jpg)










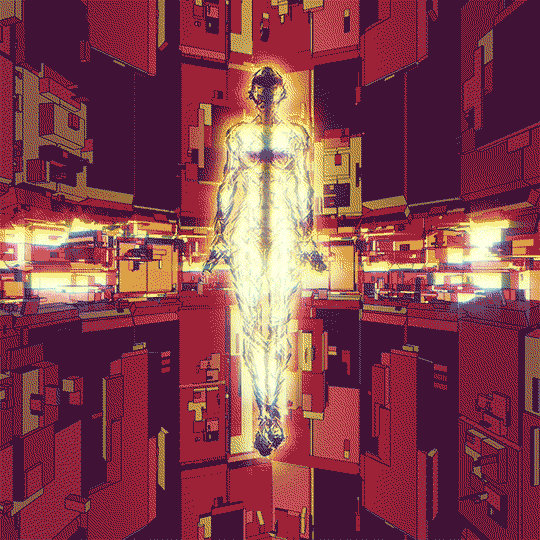
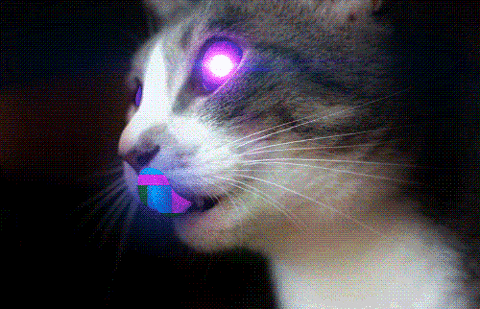





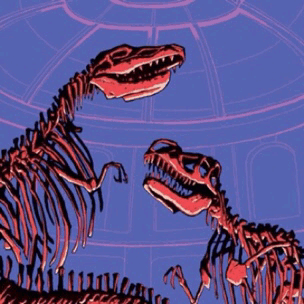

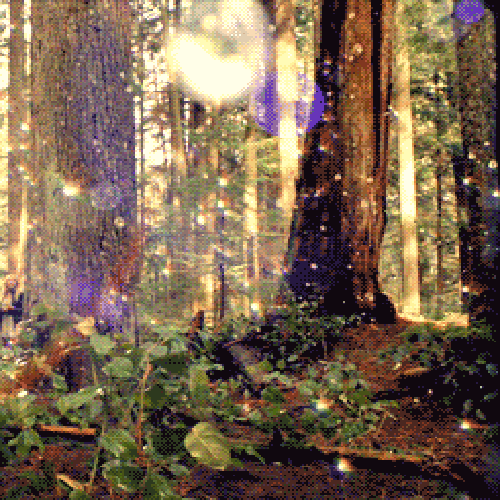

.jpg)


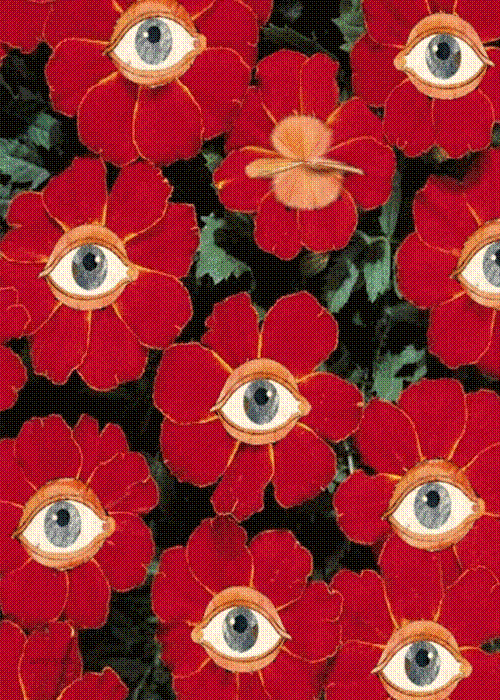
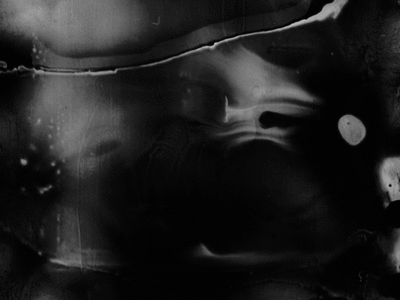


Nessun commento:
Posta un commento